I RIONI |
|---|
INTRODUZIONE
una tipica targa rionale |
Sin dalle sue origini Roma è sempre stata suddivisa in varie aree amministrative, che nel tempo hanno finito per caratterizzare i singoli distretti anche sul piano sociale e, in parte, anche su quello storico e culturale. Le pagine che seguono sono un tentativo di descrivere i quattordici rioni più antichi e centrali, tracciandone le principali note storiche e i loro maggiori elementi di interesse, con varie notizie insolite, leggende, ed altri dati meno conosciuti. Non sono da considerarsi una guida, perché i luoghi più celebri vengono appena menzionati e perché includere ogni singolo dettaglio meritevole di citazione avrebbe reso queste pagine troppo voluminose. In ogni caso, il vero oggetto di queste pagine non sono i singoli monumenti, i palazzi, le chiese, ma i rioni a cui appartengono, visti nel loro insieme, ciascuno con le proprie caratteristiche e la propria personalità. |
|---|
Al fine di localizzare più facilmente i luoghi descritti, spostando il cursore del mouse sulle rispettive immagini appariranno i nomi delle vie o piazze dove si trovano i soggetti fotografati.
Per un'introduzione generale ai rioni di Roma continuate a scorrere questa pagina oltre l'indice sottostante, oppure cliccate qui.
In ultimo, una breve nota sul tema dello sfondo scelto per queste pagine. Mostra il tipico lastricato cittadino, vagamente somigliante al basolato più largo ed irregolare in uso nell'antica Roma. Ancora oggi questi pesanti prismi di basalto che affondano nel terreno per circa 15 cm, posati uno per volta come in un mosaico, sono la più comune forma di pavimentazione romana.
sampietrino |
Sono localmente detti sampietrini, da quando furono adottati la prima volta per piazza San Pietro, verso la metà del XVI secolo, e da allora in poi sono stati utilizzati anche nel resto della città. Venivano fabbricati a mano da una squadra di scalpellini indicati come squarcioni (quelli che rompono i grossi blocchi di basalto), scoccioni (quelli che lavorano ciascun frammento fino a fargli prendere la forma la forma prismatica del sampietrino) e posatori, anche detti localmente battiserci (quelli che compiono l'ultima parte dell'opera.) |
|---|
(mappa cliccabile)
|
|
|
|---|
la posizione di alcuni fra i principali siti di interesse
Per completezza, la mappa che segue mostra l'intera estensione del comune; la tabella contiene la lista dei quartieri, situati appena al'esterno del nucleo storico, e dei suburbi, un po' più lontani dal centro. Le aree più periferiche sono divise in zone.
| ZONE I - Val Melaina II - Castel Giubileo III - Marcigliana IV - Casal Boccone V - Tor San Giovanni VI - Settecamini VII - Tor Cervara VIII - Tor Sapienza IX - Acqua Vergine X - Lunghezza XI - San Vittorino XII - Torre Spaccata XIII - Torre Angela XIV - Borghesiana XV - Torre Maura |
XVI - Torrenova XVII - Torre Gaia XVIII - Capannelle XIX - Casal Morena XX - Aeroporto di Ciampino XXI - Torricola XXII - Cecchignola XXIII - Castel di Leva XXIV - Fonte Ostiense XXV - Vallerano XXVI - Castel di Decima XXVII - Torrino XXVIII - Tor de' Cenci XXIX - Castelporziano XXX - Castelfusano |
XXXI - Mezzocamino XXXII - Acilia Nord XXXIII - Acilia Sud XXXIV - Casalpalocco XXXV - Ostia Antica XXXVI* - Isola Sacra XXXVII* - Fiumicino XXXVIII* - Fregene XXXIX - Tor di Valle XL - Magliana Vecchia XLI - Ponte Galeria XLII* - Maccarese Sud XLIII* - Maccarese Nord XLIV - La Pisana XLV - Castel di Guido |
XLVI* - Torrimpietra XLVII* - Palidoro XLVIII - Casalotti XLIX - Santa Maria di Galeria L - Ottavia LI - La Storta LII - Cesano LIII - Tomba di Nerone LIV - La Giustiniana LV - Isola Farnese LVI - Grottarossa LVII - Labaro LVIII - Prima Porta LIX - Polline Martignano * non segnate, ora appargono a Fiumicino |
Il nucleo storico di Roma è suddiviso in 22 rioni. Tale nome è una corruzione del latino regiones, le porzioni in cui la città era stata ripartita per la prima volta dal re Servio Tullio, attorno al VI secolo aC.
In origine erano solo quattro (pianta in basso a destra):
Tutte e quattro le regioni erano comprese nel pomerio, il confine sacro della città che lo stesso re aveva demarcato con grosse pietre (i punti azzurri nella pianta, cfr. anche Le mura di Roma per maggiori dettagli).
REGIONE NOME DI RIFERIMENTO Regio I Suburana (Subura da sub urbs = "margini della città", comprendente il colle Celio e le valli adiacenti) Regio II Esquilina (da ex quiliae = "fuori dell'abitato") Regio III Collina (comprendente due colli: il Quirinale e il Viminale) Regio IV Palatina (comprendente il colle Palatino e il Foro Romano)
Il Campidoglio (C nella pianta) era verosimilmente considerato un'area sacra a sé stante, in quanto vi sorgeva il maggiore Tempio di Giove ed altri ancora, così pur non facendo parte delle regioni, era comunque racchiuso entro il pomerio. Quando in età repubblicana, attorno alla metà del IV secolo aC, fu costruita una vera e propria cinta muraria (le cosiddette mura serviane), Roma si era già estesa ben oltre il confine sacro.
le prime quattro Regiones del re Servio Tullio ██ Roma repubblicana (mura serviane, IV sec. aC) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ il pomerio |
le quattordici Regiones di Ottaviano Augusto ██ Roma imperiale (mura aureliane, 275 dC) ██ Roma repubblicana |
|---|
All'inizio dell'età imperiale, poiché la città continuava a espandersi, Ottaviano Augusto (27 aC-14 dC) portò il numero delle regiones a quattordici, includendovi i territori al di fuori delle mura serviane che nel frattempo si erano popolati. La costruzione delle nuove mura, però, non si ebbe che quasi tre secoli dopo, sotto Aureliano. I nomi delle regiones si riferivano a ciò che di importante le caratterizzava, sebbene per identificarle venissero comunemente usati anche solo i rispettivi numeri:
| REGIONE | NOME DI RIFERIMENTO |
Regio I | Porta Capena (la porta più meridionale delle Mura Serviane) |
| Regio II | Caelemontium (il Colle Celio e le sue alture minori) |
| Regio III | Isis et Serapis (divinità egizie a cui era dedicato un famoso tempio) |
| Regio IV | Templum Pacis |
| Regio V | Esquiliae (cioè "al di fuori dell'area edificata") |
| Regio VI | Alta Semita |
| Regio VII | Via Lata (antico nome del tratto urbano di via Flaminia) |
| Regio VIII | Forum Romanum vel Magnum |
| Regio IX | Circus Flaminius |
| Regio X | Palatium |
| Regio XI | Circus Maximus |
| Regio XII | Piscina Publica |
| Regio XIII | Aventinus |
| Regio XIV | Transtiberim (la riva occidentale del Tevere) |
Ulteriori distruzioni e modifiche Roma le subì nell'alto Medioevo, con le guerre gotiche e le invasioni barbariche. Man mano che l'impero romano si sgretolava, anche l'amministrazione civica perdeva progressivamente i suoi poteri. Sin dal IV secolo cominciò ad entrare in uso una suddivisione non ufficiale del territorio urbano basata sulla giurisdizione religiosa (cioè la divisione della città in distretti, anche detti Regiones, facenti riferimento alle principali chiese locali che fungevano da parrocchia). Erano compresi i seguenti sette distretti:
| REGIONE | NOME / RIFERIMENTO | |
Regio I | Aventinensis vel Horrea | dell'Aventino, oppure i Depositi di grano |
| Regio II | iuxta IV Coronatorum... | presso i [Santi] Quattro Coronati... |
| Regio III | iuxta porta Maiore | presso Porta Maggiore (anche detta Porta Praenestina) |
| Regio IV | qui appellatur Campum Sanctae Agathae | che è chiamato Campo di Sant'Agata |
| Regio V | iuxta arco marmoreo | presso l'arco di marmo (in via Lata, oggi scomparso) |
| Regio VI | ad Sancta Maria in Sinikeo | presso Santa Maria in Sinikeo |
| Regio VII | ad Sanctum Petrum | presso San Pietro (è l'antica Regio XIV, Transtiberim) |
Nonostante la nuova ripartizione religiosa, ancora per molti secoli le regiones originarie istituite da Ottaviano Agusto ufficialmente non decaddero; ma più passava il tempo, più la suddivisione del territorio appariva confusa.
Un documento firmato da papa Leone VIII (963-964) fa riferimento ai rappresentanti di quindici Regiones, i cui nomi sembrano essere una commistione di quelli amministrativi più antichi e di quelli religiosi descritti in precedenza. Erano verosimilmente usati in via non ufficiale, cioè non per fini amministrativi né religiosi, bensì solo per indicare una certa zona col nome di un suo luogo o edificio importante. Solo tre di questi nomi citano la numerazione progressiva della rispettiva Regio, che per tutti gli altri rimane ignota.
| NOME / RIFERIMENTO | ||
Regio prima Aventini | prima Regione, dell'Aventino | |
| Regio secunda Mamertini | seconda Regione, del Mamertino [1] | |
| Regio optava sub Capitolio | ottava Regione, sotto il Campidoglio (l'area del Foro Romano) | |
| Regio de Vico Patricii | Regione di Vicolo dei Patrizi (località non identificata) | |
| Regio Caput tauri | Regione Testa di toro (Porta Tiburtina) | |
| Regio clivi argentarii | Regione del clivo degli Argentarii | |
| Regio ad duos (amantes) | Regione presso i due amanti (località non identificata) | |
| Regio liberatica | Regione Liberatica [2] | |
| Regio Sisinii | Regione di Sisinio (località non identificata) | |
| Regio via Lata | Regione via Lata | |
| Regio Coelio Monte | Regione Colle Celio | |
| Regio urbis Ravenne | Regione della città di Ravenna (Trastevere) [3] | |
| Regio ad gallinas albas | Regione presso le galline bianche [4] | |
| Regio horrea | Regione dei depositi di grano (Aventino) | |
| Regio secus porta Metronii | Regione lungo Porta Metronia |
note |
| Nel 1144 i Senatori, che a quei tempi governavano la città, decisero di riordinare il territorio abitato di Roma (assai meno esteso che in epoche precedenti) in dodici distretti, ancora chiamati regiones nei documenti ufficiali, che però non comprendevano più né l'Isola Tiberina, né alcuna area sulla sponda occidentale del fiume. Infatti Trastevere - "al di là del Tevere" - entrò nuovamente a far parte della lista ufficiale di regiones solo all'inizio del XIV secolo. Di questo riordinamento non se ne trova ancora traccia nelle prime edizioni dei Mirabilia Urbis Romae ("meraviglie della città di Roma"), la famosa lista e guida dei principali luoghi della città, redatta in latino attorno alla metà del XII secolo a beneficio dei numerosi pellegrini che venivano a Roma per visitare la tomba di San Pietro.
← parte della pianta di Roma di Fra' Paolino (1340 c.ca), orientata verso est, che mostra la
porzione meridionale della città: al centro si vedono gli archi dell'acquedotto neroniano che corrono dalla
chiesa di Santa Croce in Gerusalemme; poco sotto a quest'ultima è il Laterano con San Giovanni,
dove si vedono la statua equestre di Marco Aurelio ed i frammenti (testa, mano) della colossale statua
di Costantino, ora nei Musei Capitolini; ancora più in basso la massa scura è il colle Celio;
lungo il margine destro passano le mura aureliane; in alto a sinistra è il colle Esquilino, con
Santa Maria Maggiore; infine, in basso a sinistra, il Colosseo è coperto da una bizzarra cupola, forse un tentativo di rappresentarne il velario |
Invece ne Le miracole de Roma, che in pratica era una traduzione in volgare della suddetta guida ai Mirabilia ma con alcune aggiunte, databile all'incirca al XIII secolo, una suddivisione in dodici rioni viene effettivamente citata:
Regio Prima: Porta Capena, la dov'è la casa de lo Honore et de la Virtute, ....
Regio Secunda: Celio monte, là dove era lo Macello de Claudio et lo maiure vordello de Roma, ....
Regio Terza, là dove era lo Palazo de Yside et de Serapis, ....
Regio Quarta, la dove era templum Pacis ....
Regio Quinta, la dove era lo Pozo de Orpheo et lo Macello de Laviano ....
Regio Sexta: Alta Via, la dove era lo Templo de Salustio et de Serapis ....
Regio Septima: Via Lata, lo quale avea lo Pozo de Ganimede ....
Regio Octava: lo Mercato Maiure de Roma ....
Regio Nona: Palatio Maiure, et avea la Casa de Romulo ....
Regio Decima avea Templum Solis et Lune, et Templum Mercurii ....
Regio Undecima: Piscina Publica ....
Regio Duodecima: Aventino ....
Regio Tertiadecima ène Trastebere ....
| La lista evidenzia chiaramente come l'antica ripartizione augustea, considerata dagli eruditi essere quella "classica", veniva ancora usata per fini culturali, nonostante fosse ormai priva di valore dal punto di vista amministrativo e burocratico.
un'altra porzione della pianta di Fra' Paolino, → relativa al Vaticano, con San Pietro (in basso) e l'obelisco sul fianco destro; in alto a sinistra è il Castello; la forma scura a destra è il Gianicolo Un'edizione tarda del Mirabilia, databile al 1220-26, rinvenuta in una biblioteca in Austria, riporta un ordinamento piuttosto complesso in ben 26 rioni. |
| Prima regio dicitur porticus Sancti Petri, | Il primo rione è detto portico di San Pietro [1] |
| secunda pons Sancti Petri, | il secondo, ponte di San Pietro |
| III scorteclari | il III, gli scuoiatori (pellai) |
| IV parrio | il IV, Parione [2] |
| V Sanctus Laurentius in Damaso | il V, San Lorenzo in Damaso |
| VI campus Martis | il VI, il Campo Marzio |
| septima Sanctus Laurentius in Lucina, | il settimo, San Lorenzo in Lucina |
| octava columpna Antonini coclidis, | l'ottavo, colonna coclide di Antonino |
| IX Sancta Maria in Aquiro, | il IX, Santa Maria in Aquiro |
| X Sanctus Eustachius, | il X, Sant'Eustachio |
| XI vinea Tedemari, | l'XI, vigna di Tedemario |
| XII Areola, | il XII, Areola (località non identificata) |
| XIII Caoccavaia, | il XIII, Caoccavaia (località non identificata) |
| XIV S.Angelus piscivendoli, | il XIV, Sant'Angelo dei pescivendoli |
| Quintadecima Pinea, | La quindicesima, Pigna |
| Sextadecima S.Marcus, | La sedicesima, San Marco |
| VIIdecima Trivium, | la diciassettesima, Trivio |
| Octadecima Violata, | La diciottesima, Violata [3] |
| Nonadecima Campitellus, | La diciannovesima, Campitelli |
| Vicesima S.Adrianus, | La ventesima, Sant'Adriano |
| Vicesima I Biberatica, | La ventunesima, Biberatica [4] |
| Vicesima II Montes vel Lateranum, | La ventiduesima, Monti ovvero il Laterano |
| Vicesima III Ripa, | La ventitreesima, Ripa | Vicesima IV Marmorata, | La ventiquattresima, Marmorata | Vicesima V Insula, | La venticinquesima, l'Isola | Vicesima VI Transtyberim | La ventiseesima, Oltretevere (Trastevere) |
note |
pianta dei principali luoghi di Roma (1472), orientata verso sud; la Città Leonina (in basso a destra) era una cittadella indipendente |
Un catalogo delle chiese di Roma compilato in volgare circa un secolo e mezzo dopo, nel tardo Trecento, cita nuovamente i nomi dei rioni, evidenziando che nel frattempo era intervenuto un chiaro cambiamento, come mostra la tabella seguente. Il testo (cfr. tabella seguente) comincia con le parole: Nella città vi sono tredici Regioni, che vengono chiamate col vocabolo corrotto e popolare di Rioni. Di queste la prima è la Regione Monti e Biberatica.Pertanto, nonostante fosse cambiato l'ordine dei rioni, l'uso di accostare al loro nome un luogo o un edificio importante fu mantenuto ancora per un certo tempo. Il riferimento aggiuntivo era costituito il più delle volte dalla principale chiesa del rione. |
|---|
Questo ordinamento non è solo quello in cui si fa per la prima volta riferimento al vocabolo Rioni, ma anche quello in cui i loro nomi sono pressoché coincidenti con quelli in uso tutt'ora, sebbene i confini fossero in parte diversi. La tabella che segue ne mette a confronto i nomi e la numerazione progressiva.
| NOMI ED ORDINAMENTO DEI RIONI NEL XIV SECOLO | ||
In urbe sunt Tredecim Regiones. Que corrupto et vulgari vocabulo dicuntur Rioni. |
||
| Quarum Prima est Regio Montium et Biberate. | I. Monti (coincidente) | |
| Secunda. Regio Trivi et Vielate. | II. Trevi (coincidente) | |
| Tertia. Regio Colupne et sancte Marie in Aquiro. | III. Colonna (coincidente) | |
| Quarta. Regio Posterule et sancti Laurentii in Lucina. | IV. Campo Marzio | |
| Quinta. Regio Pontis et Scortichiariorum. | V. Ponte (coincidente) | |
| Sexta. Regio sancti Eustachii et vinee Tedemarii. | VI. Parione | |
| Septima. Regio Arenule et Chacabariorum. | VII. Regola (coincidente) | |
| Octava. Regio Parionis et sancti Laurentii in Damaso. | VIII. Sant'Eustachio | |
| Nona. Regio Pinee et sancti Marci. | IX. Pigna (coincidente) | |
| Decima. Regio Sancti Angeli in foro piscium. | X. Campitelli | |
| Undecima. Regio Ripe et Marmorate. | XI. Sant'Angelo | |
| Duodecima. Regio Campitelli in sancti Adriani. | XII. Ripa | |
| Tertiodecima. Regio Transtiberim. | XIII. Trastevere (coincidente) |
| Dei rioni attuali, sette coincidono per nome e ordinamento e cinque di essi hanno lo stesso nome ma una diversa posizione sequenziale; solo uno (Campo Marzio) ha un nome diverso. Questi nomi fanno anche pensare che la lunga lista di 26 rioni riportata dall'edizione tarda del Mirabilia trovata in Austria, descritta in precedenza, potrebbe essere nata in seguito ad una erronea interpretazione, cioè spezzando queste dodici doppie definizioni in ventiquattro nomi singoli.
Probabilmente verso la fine del medioevo presero forma anche gli stemmi rappresentativi di ciascun rione, la cui immagine è rimasta invariata. ← descrizione degli stemmi rionali in una pubblicazione del 1545; i rioni non sono citati in ordine numerico e manca ancora Borgo |
| Alla fine del XVI secolo anche la Città Leonina (ovvero l'area del Vaticano), rimasta fino ad allora un'enclave suburbana, ma già circondata da mura sin dai tempi di papa Leone IV (847-855), venne ufficialmente inclusa da Sisto V (1585-90) nel territorio urbano di Roma, divenendone il quattordicesimo rione. Nel 1743 papa Benedetto XIV riorganizzò i quattordici rioni; l'anno seguente i loro perimetri furono demarcati mediante affissione di un totale di 220 targe di marmo lungo le strade dove passavano i loro confini. Quando mezzo secolo dopo Roma subì la prima occupazione da parte delle milizie di Napoleone, con un'ordinanza i distretti amministrativi della città furono rinominati Sezioni e i loro nomi mutarono; alcuni furono accorpati, altri divisi, secondo la tabella seguente. l'ordinanza emanata il 16 ventoso (6 marzo, secondo il calendario della → Rivoluzione Francese) del 1798; cliccare sull'immagine per ingrandirla |
|
|---|
I. Rione Monti (diviso in due parti) " " II. Rione Trevi III. Rione Colonna IV. Rione Campo Marzio V. Rione Ponte VI. Rione Parione più VII. Rione Regola VIII. Rione Sant'Eustachio IX. Rione Pigna più XI. Rione Sant'Angelo X. Rione Campitelli più XII. Rione Ripa XIII. Rione Trastevere XIV. Rione Borgo |
→ → → → → → → → → → → → | Sezione delle Terme Sezione della Suburra Sezione del Quirinale Sezione del Pincio Sezione di Marte Sezione di Bruto Sezione di Pompeo Sezione di Flaminio Sezione del Pantheon Sezione del Campidoglio Sezione del Gianicolo Sezione del Vaticano |
|---|
L'amministrazione francese rimosse anche tutte le targhe rionali esistenti.
Terminata l'occupazione, nel 1814 fu ripristinata l'antica suddivisione in quattordici rioni, nonché i loro confini originali, che da allora non sono cambiati. Le targhe furono nuovamente collocate nelle vie e gran parte di esse si possono ancora vedere su molti palazzi antichi; alcune sono state ripulite e restaurate, mentre su altre sono chiaramente visibili i segni dell'età.
Poco dopo la caduta dello Stato Pontificio (1870), gli amministratori capitolini raggrupparono i rioni in distretti amministrativi più ampi, per i quali fu ripristinato il termine Regioni (come le antiche Regiones):
Tale riordinamento non durò a lungo, venendo abbandonato prima del volgere del nuovo secolo; ben presto i Rioni tornarono ad essere quattordici unità amministrative individuali.
Nel 1874 il rione più esteso, Monti (I), fu separato in due metà: la parte più centrale mantenne il vecchio nome, mentre la parte orientale, che andava ripopolandosi, divenne il rione Esquilino (XV).
Un particolare curioso è che in questa suddivisione amministrativa i numerosi ponti romani (oggi sono ben quattordici quelli che attraversano il Tevere lungo il centro storico della città, racchiuso nel circuito delle antiche mura aureliane) rappresentano un po' delle "zone franche", così come lo è lo stesso corso del fiume, ufficialmente non appartenendo ad alcuno dei rioni, dato che i confini di questi ultimi seguono sempre i lungoteveri dal rispettivo lato. Per ragioni storiche, fa eccezione Ponte Sant'Angelo, il quale, pur dando il nome al rione Ponte, dalla fine del Cinquecento appartiene a Borgo.
Nonostante la continua espansione di Roma - dagli anni '20 a oggi la sua superficie si è più che triplicata - dopo Prati nessun'altra successiva porzione urbana fu investita del titolo di rione: la città moderna venne divisa in quartieri, il cui numero è salito a trentacinque, e in suburbi, attualmente sei, nonché cinquantuno zone di periferia cittadina, in continua espansione (cfr. piantina all'inizio della pagina).
Sebbene oggi di tali sentimenti siano rimaste ben poche tracce, meno di un secolo fa erano ancora molto vive: nel 1927 il governatore di Roma commissionò all'architetto Pietro Lombardi un certo numero di fontanelle rionali, a beneficio dei rispettivi abitanti, la cui forma fu ispirata agli elementi caratteristici di ciascun rione.
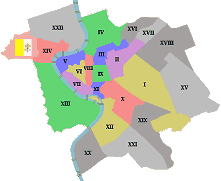
i testi e le illustrazioni contenuti in questo sito costituiscono proprietà intellettuale dell'autore, ove non diversamente specificato;
solo le immagini raffiguranti antichi disegni, dipinti e incisioni, fotografie d'epoca nonché il materiale proveniente da Wikimedia Commons sono di pubblico dominio
Terminata l'occupazione, nel 1814 fu ripristinata l'antica suddivisione in quattordici rioni, nonché i loro confini originali, che da allora non sono cambiati. Le targhe furono nuovamente collocate nelle vie e gran parte di esse si possono ancora vedere su molti palazzi antichi; alcune sono state ripulite e restaurate, mentre su altre sono chiaramente visibili i segni dell'età.
Poco dopo la caduta dello Stato Pontificio (1870), gli amministratori capitolini raggrupparono i rioni in distretti amministrativi più ampi, per i quali fu ripristinato il termine Regioni (come le antiche Regiones):
| RIONI RIUNITI | REGIONI | |
I. Monti più X. Campitelli |
Regione I, Campidoglio |
|
| II. Trevi più VI. Parione più VIII Sant'Eustachio più IX. Pigna | Regione II, Pantheon | |
| III. Colonna più IV. Campo Marzio | Regione III, Campo Marzio | |
| V. Ponte più VII. Regola più XIV. Borgo | Regione IV, Adriana | |
| XI. Sant'Angelo più XII. Ripa più XIII. Trastevere | Regione V, Tiberina |
Tale riordinamento non durò a lungo, venendo abbandonato prima del volgere del nuovo secolo; ben presto i Rioni tornarono ad essere quattordici unità amministrative individuali.
(↑) bizzarra commistione di antico e di nuovo nel rione Regola e un'altra targa nel rione Sant'Eustachio (→) accanto a un divieto di fare il "mondezzaro" (XVIII secolo) |
|---|
Nel 1874 il rione più esteso, Monti (I), fu separato in due metà: la parte più centrale mantenne il vecchio nome, mentre la parte orientale, che andava ripopolandosi, divenne il rione Esquilino (XV).
| Nel 1921 il Comune procedette a un riordinamento dei rioni. Anche Trevi (II) e Colonna (III) furono divisi e le loro metà più periferiche, in pieno sviluppo edilizio, vennero dichiarate rioni autonomi: rispettivamente Sallustiano (XVII) e Ludovisi (XVI). Contemporaneamente anche Castro Pretorio (XVIII) divenne autonomo, separandosi dall'Esquilino, mentre nella parte meridionale di Roma dall'accorciamento di Campitelli (X) nacque il Celio (XIX), e dalle porzioni più esterne di Ripa (XII) si staccarono Testaccio (XX) e San Saba (XXI). Infine, sempre nel 1921, anche l'area urbana sulla riva occidentale del Tevere, che tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento si era sviluppata a nord di Borgo (XIV), venne dichiarata rione col nome di Prati (XII), che si rifaceva all'antica denominazione prati di Castello per indicare i vasti terreni coltivati alle spalle di Castel Sant'Angelo; questo è l'unico rione situato fuori della cinta muraria. Borgo invece, subì il dimezzamento del proprio territorio quando nel 1929 con la firma dei Patti Lateranensi la sua parte occidentale collinosa divenne uno stato autonomo, la Città del Vaticano. |
la nascita dei nuovi rioni: le aree rigate indicano le parti successivamente divenute autonome |
|---|
Un particolare curioso è che in questa suddivisione amministrativa i numerosi ponti romani (oggi sono ben quattordici quelli che attraversano il Tevere lungo il centro storico della città, racchiuso nel circuito delle antiche mura aureliane) rappresentano un po' delle "zone franche", così come lo è lo stesso corso del fiume, ufficialmente non appartenendo ad alcuno dei rioni, dato che i confini di questi ultimi seguono sempre i lungoteveri dal rispettivo lato. Per ragioni storiche, fa eccezione Ponte Sant'Angelo, il quale, pur dando il nome al rione Ponte, dalla fine del Cinquecento appartiene a Borgo.
Nonostante la continua espansione di Roma - dagli anni '20 a oggi la sua superficie si è più che triplicata - dopo Prati nessun'altra successiva porzione urbana fu investita del titolo di rione: la città moderna venne divisa in quartieri, il cui numero è salito a trentacinque, e in suburbi, attualmente sei, nonché cinquantuno zone di periferia cittadina, in continua espansione (cfr. piantina all'inizio della pagina).
nell'ottava 10 del primo Canto de Il maggio romanesco, poema eroicomico di Giovanni Camillo Peresio, vengono citati i nomi di dodici rioni; essendo ambientato nel Trecento, Borgo non è incluso, ma è omesso anche Sant'Eustachio, forse per motivi di metrica (ediz. orig., 1688) |
In passato, il senso di appartenenza al proprio rione era sentito in maniera forte dai rispettivi abitanti: era infatti il contesto dove la gente comune trascorreva la maggior parte della propria vita. In ogni rione vigeva una certa gerarchia, a capo della quale era il caporione: questi veniva scelto dalle famiglie nobili e, dalla seconda metà del XVIII secolo, direttamente dal papa. Poiché Monti era considerato il rione più importante, il suo caporione aveva il privilegio di far parte dei Magistrati, e quindi della ristretta cerchia della classe governante. Ciò è sempre stato motivo di vanto per i locali abitanti, i monticiani. Nel XIX secolo tale carica venne modificata in quella di presidente del rione. |
|---|
| Il caporione si affidava spesso ai giovani abitanti del luogo, i quali, individualmente o in bande, agivano quasi come un "esercito rionale": i loro servigi ne facevano aumentare il prestigio sociale e il rispetto fra la propria gente. Infatti, mentre all'interno dei confini rionali c'erano rapporti di buon vicinato, una certa rivalità esisteva fra gli abitanti di rioni diversi, specialmente se grandi e popolari come Monti e Trastevere. Le offese al codice d'onore, cioè gli sgarri, potevano facilmente innescare conflitti sanguinosi fra bande delle opposte fazioni. Ogni rione andava orgoglioso delle proprie piazze, edifici e monumenti. Soprattutto alle chiese si dedicavano particolari attenzioni, così come ne ricevevano anche luoghi di culto minori, quali le cappelle stradali e le centinaia di altarini dedicati alla Madonna, popolarmente chiamate madonnelle, sugli angoli di molti palazzi, le cui spese di manutenzione venivano pagate dagli abitanti rionali con le proprie offerte. |
madonnella seicentesca di Palazzo Ricci |
|---|
Sebbene oggi di tali sentimenti siano rimaste ben poche tracce, meno di un secolo fa erano ancora molto vive: nel 1927 il governatore di Roma commissionò all'architetto Pietro Lombardi un certo numero di fontanelle rionali, a beneficio dei rispettivi abitanti, la cui forma fu ispirata agli elementi caratteristici di ciascun rione.
fontanella rionale per Monti ed Esquilino |
Quella a destra è la Fontana delle Palle di Cannone, per Borgo, prossima a Castel Sant'Angelo, mentre la forma di quella mostrata qui in alto richiama i tre colli di Monti. Le rimanenti vengono descritte nelle altre pagine di questa sezione. | la fontanella delle Palle di Cannone |
|---|
i testi e le illustrazioni contenuti in questo sito costituiscono proprietà intellettuale dell'autore, ove non diversamente specificato;
solo le immagini raffiguranti antichi disegni, dipinti e incisioni, fotografie d'epoca nonché il materiale proveniente da Wikimedia Commons sono di pubblico dominio